Partiamo dai numeri, almeno da quelli che si conoscono. In Italia si contano oltre 23.500 immobili confiscati alle mafie concentrati soprattutto in 6 regioni (in ordine Sicilia, Campania, Calabria, Puglia, Lazio, Lombardia) e più di 3.500 aziende confiscate.
Sappiamo che i beni confiscati rappresentano un importante strumento di contrasto alle mafie, perché da una parte scalfiscono il loro potere dal punto di visto simbolico (il che in alcuni territori vuol dire davvero tanto) e dall’altra offrono un’opportunità concreta di rivalsa per le comunità, creando occasioni di sviluppo oltre che di coesione sociale. In termini più semplici, i beni riutilizzati sono lo Stato che vince sulla mafia, sono la dimostrazione che questo è possibile e soprattutto che un modello alternativo di società e di economia è praticabile. Conosciamo decine di esperienze virtuose che hanno sperimentato modelli di gestione sostenibili, che funzionano, che mettono insieme istituzioni e società civile, che sono la legalità, l’interesse collettivo che vincono sul sistema criminale e l’interesse mafioso.
Il problema qual è? E’ che purtroppo i casi di riutilizzo sono solo una piccola parte (un lavoro di Libera ne ha censiti circa 500, ma non esitono dati su quanti beni sono effettivamente riutilizzati) rispetto alle decine di migliaia di beni confiscati e non utilizzati. Il problema è che, rovesciando la logica del ragionamento fatto prima, questa grande quantità di beni abbandonati, spesso ridotti all’impraticabilità dalle devastazioni dopo la confisca, e di aziende che falliscono, con tutto ciò che ne consegue per l’occupazione e l’economia locale, sono i “simboli” e la prova dei fatti che lo Stato rischia di perdere sui territori. Il problema è che, per evitare la disfatta, questi beni possono e devono essere recuperati e valorizzati, devono produrre valore aggiunto per i territori e cioè sviluppo e comunità.
Perché questo non accade? Partiamo anche qui dai dati, questa volta però da quelli che mancano.
Cosa sono e dove si trovano esattamente questi beni, in che condizioni versano, se e come possono essere riutilizzati, non è dato saperlo. Nonostante i 21 milioni di euro destinati a due sistemi informativi per lo scambio di dati e informazioni sui beni sequestrati e confiscati. Manca una mappatura, ma non è l’unica cosa che non va. Su migliaia di aziende confiscate, pochissime hanno ripreso l’attività e solo una decina sono date in gestione a cooperative di dipendenti, mentre un numero troppo elevato è in carico all’ANBSC (Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati) che non ha ancora deciso la destinazione. Non esistono invece dati sui beni mobili (vetture, natanti, ecc).
Passiamo a un altro dato. L’attuale normativa prevede che le somme di denaro confiscate affluiscano al Fondo unico di giustizia (FUG) che, anche se non vi sono dati certi sullo stock e sui flussi di risorse, è stimato in circa 3,5 miliardi di euro. Il Fondo non è alimentato solo dalle risorse economiche o finanziarie confiscate alla mafia e, comunque, non tutte affluiscono nel fondo. Tra le criticità, peraltro segnalate anche dalla Corte dei Conti, vi è la destinazione delle risorse: molteplice e non sempre rispondente a logiche e interventi normativi lineari.
Quelli appena elencati sono i dati relativi ad alcune contraddizioni denunciate all’interno di un documento presentato lo scorso luglio da un gruppo di lavoro coordinato dalla Fondazione CON IL SUD, composto da Fondazioni e Forum Terzo Settore, che propone una “profonda revisione” del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati.
A che punto siamo? Il percorso avviato più di vent’anni fa da Libera con la raccolta di oltre 1 milione di firme che ha portato alla faticosa conquista di una legge, la 109/96, sul riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie che impedisce ai condannati di reati di stampo mafioso di rientrare in possesso dei beni sequestrati, rappresenta un punto alto del contrasto alle mafie e più direttamente della nostra democrazia. L’Italia è il paese con la legge più avanzata al mondo su questo tema e, come anticipato, è anche il paese che ha avviato tantissime sperimentazioni ed esperienze che indicano modelli sostenibili ed efficaci di gestione, di partecipazione e di contrasto concreto al potere mafioso.
Ma oggi? Siamo veramente impantanati? Nel corso degli anni si sono registrate piccole manutenzioni legislative e proposte condizionate da schemi ideologici che non hanno permesso di fare veramente dei salti in avanti. Ma la domanda più importante è se, al netto degli annunci politici cui siamo abituati, la gestione dei beni confiscati interessi davvero i nostri decisori e sia una priorità per la lotta alla mafia e se questa, infine, lo sia per il paese. I dati citati prima e l’impasse nella discussione parlamentare attorno al testo sul nuovo codice antimafia, anche se di per sé non risolutivo del problema, fermo da due anni al Senato ci dimostrano che il percorso da compiere non è per nulla semplice. Il rischio più grande è che l’immobilismo, in senso legislativo e anche rispetto alle buone intenzioni, porti quel “pragmatismo funzionale” del contrasto alle mafie conosciuto dalla morte di Falcone e Borsellino e con la legge 109/96 a cedere via via il passo alla sola retorica. Il che vorrebbe dire svilire, svuotare di senso e di reale prospettiva di successo non solo il lavoro di associazioni, cooperative sociali, l’impegno di pezzi di società civile e migliaia di cittadini, istituzioni, nel contrasto al potere mafioso attraverso lo strumento dei beni confiscati, ma complessivamente la lotta dello Stato alla mafia. Quando suonerà la sveglia?
Attraverso questo numero non vogliamo, né possiamo, fornire risposte esaustive a questi interrogativi, intendiamo però proporre all’attenzione dei lettori l’urgenza della questione e delle soluzioni possibili, concrete, attraverso riflessioni e testimonianze di esperti e operatori, nonché mettendo a fuoco il punto di vista delle forze politiche del paese. Lo abbiamo chiesto lo scorso marzo ai rappresentati dei principali partiti e movimenti del nostro Parlamento, ponendo loro alcune domande, le stesse per tutti. Al momento non abbiamo ricevuto risposte, ma siamo ben lieti e disponibili a pubblicarle se e quando le riceveremo.
Con questo approfondimento, che come consuetudine del magazine resterà aperto per tre mesi per accogliere eventuali ulteriori contributi e riflessioni, avviamo inoltre la collaborazione con l’associazione Italia che cambia, per il comune obiettivo di raccontare il cambiamento “dal basso” nel nostro paese, attraverso esperienze e buone pratiche che fanno ben sperare.


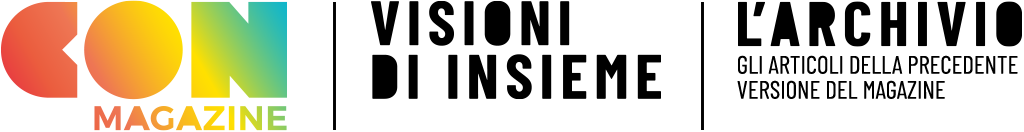




Nessun Commento