Liat Rogel, un dottorato di ricerca in design di servizi al Politecnico di Milano, esperta e appassionata di abitazioni sociali e collaborative, è convinta che anche in città si possano tessere relazioni di buon vicinato: “riscoprire la dimensione conviviale dell’abitare fa vivere meglio e spendere meno”, dice. Nel 2014 ha fondato l’associazione Housing Lab, punto di riferimento in Italia (e non solo) nel settore delle case in condivisione. Al telefono da Milano, spiega perché cooperare con i propri vicini può essere una soluzione al problema della povertà abitativa. Anche al Sud.
Che lavoro fa Housing Lab?
Cerchiamo di diffondere la buona pratica delle abitazioni sociali e collaborative. Mi occupo di questi temi da diversi anni, li ho osservati in Danimarca, Svezia, Germania e poi anche in Italia. La mia tesi di dottorato si è concentrata su due casi sperimentali a Milano. Chi vive condividendo certi spazi, servizi, attività e decisioni risparmia soldi, inquina meno e si sente più appagato. Così è nata l’esigenza di creare un’associazione che facesse conoscere le esperienze già avviate e aiutasse chi vuole avvicinarsi a questo modo di abitare, sia nell’ambito privato che pubblico.
Nel 2017 avete “censito” le esperienze presenti nel Paese. Quante sono?
Abbiamo trovato 40 progetti. Abitare collaborativo è un termine non ancora codificato in modo unitario: dal co-housing alla cooperativa di abitanti, dal condominio solidale all’eco-villaggio. Si va da strutture con 10 alloggi a complessi di oltre 80 appartamenti. Si concentrano soprattutto nelle città del Nord, in particolare in Piemonte e Lombardia, con alcuni esempi anche in Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e in Toscana. Oltre un terzo degli abitanti ha tra i 36 e i 65 anni, il 28% va dai 19 ai 35 anni e il 19,2% è over 60. Ci sono molti bambini e ragazzi: più del 14%. (Il report della mappatura è disponibile qui)
Che criterio avete usato per la selezione dei casi da mappare?
La mappatura prende in considerazione tutti i progetti che soddisfano almeno due dei tre seguenti requisiti: l’esistenza di spazi comunitari esterni e interni, come delle sale comuni, un’area giochi, un giardino, un terrazzo, una lavanderia, un orto o un’officina per le biciclette; la presenza di servizi o attività gestiti dalla comunità di abitanti: per esempio molti organizzano corsi sportivi per bambini o adulti, hanno costituito un gruppo di acquisto solidale, organizzano periodicamente feste, aperitivi, momenti di socialità, condividono le baby-sitter; l’adozione di un processo di progettazione partecipata: le decisioni vengono prese insieme cercando di rispettare le esigenze di tutti.
Le assemblee condominiali di solito sono litigiose e sfiancanti: perché in un co-housing dovrebbe andare meglio?
Anche noi discutiamo, ovviamente. Ma una cosa è scendere di casa e trovarti in mezzo a 50 estranei, persone che quasi non saluti in ascensore, di cui sai poco e niente. In quel caso, è facile arrivare allo scontro. Discutere con gente con cui hai familiarità è molto diverso. Se sai che il signore che incontri tutte le settimane all’aperitivo comunitario fa i turni di notte, cerchi insieme a lui una soluzione per far giocare i tuoi figli in uno spazio che protegga il suo riposo.
Abita in uno di questi progetti?
Sì, da sei anni abito al Villaggio cooperativo Scarsellini, un complesso di 100 appartamenti nello storico quartiere di Affori, a Milano. Abbiamo due grandi sale comuni, attrezzate con cucina, un’area di gioco per i bambini, dei libri e la possibilità di organizzare lezioni sportive. Ci sono ovviamente alti e bassi. In certi periodi organizziamo un sacco di appuntamenti conviviali, corsi o conferenze, stiamo molto insieme. In altri momenti è come se l’energia scendesse di intensità e per esempio non riusciamo nemmeno ad organizzare una festa in maschera per carnevale.
Sembra un modo di vivere più allegro ma anche impegnativo, che esige organizzazione e tempo: ne vale la pena?
È vero, a volte può sembrare faticoso. Ma, come spieghiamo anche nel libro che abbiamo appena pubblicato (Co-housing. L’arte di vivere insieme), quello che chiede lo restituisce in modo amplificato e prolungato. Per esempio, se torni stanca dal lavoro puoi stare a bere una birra con un’amica, mentre i figli giocano insieme lì di fianco. Quello che ti viene richiesto è di mettere in ordine dopo e pulire a fondo due volte all’anno. Nel frattempo sei riuscita a ritagliarti un momento di svago, risparmiando soldi della baby sitter.
La condivisione fa risparmiare?
Certo. Le strutture di cohousing spesso vengono restaurate o costruite ex novo e quindi presentano una classe energetica efficiente: le bollette sono più leggere. La presenza di spazi comuni e disponibili per tutti fa sì che gli appartamenti familiari possano essere più piccoli e quindi costino meno: la mia cucina è piccola, ma se voglio fare un pranzo con i parenti ci organizziamo nella grande cucina comune. Poi c’è un risparmio quotidiano derivante dalla non-proprietà di servizi, utenze o elettrodomestici: abbonamento wifi, lavatrici, passeggini, giocattoli, libri, attrezzi… sono in comune.
Quindi l’abitare condiviso potrebbe essere una soluzione per la povertà abitativa?
Sì perché la condivisione di spazi, servizi, tempo e competenze genera complessivamente una minore incidenza del costo della casa sul reddito familiare.
Può funzionare al Sud?
Siamo sicuri di sì perché le reti familiari e di vicinato sono molto più solide al Sud rispetto ai paesi nordici in cui il co-housing è nato, quasi come una risposta all’isolamento che si vive nei grandi centri, dove spesso ci si ritrova per lavoro, senza famiglia, con una rete di appoggio da ricostruire da zero. Inoltre al meridione i favori tra vicini, la condivisione, la vita di quartiere sono senz’altro più sviluppati. Per questi fattori il Sud sembra avere una predisposizione naturale per l’abitare sociale e collettivo. Purtroppo ancora è meno forte la spinta per l’innovazione, per trasformare in modello abitativo l’“istinto” alla cooperazione.
Se dovesse dare un consiglio alla ministra del Sud?
Le case popolari o le abitazioni sfitte di proprietà pubblica o privata, sono un punto di partenza. Il trucco in più è coinvolgere gli abitanti nel processo di creazione di uno spazio condiviso, metterle attorno a un tavolo, chiedere e ascoltare: come immagini la tua casa? Di che spazi hai bisogno? E i tuoi figli? Come puoi dare una mano al tuo vicino? In questo modo le persone – anche se si trovano in una situazione di difficoltà (non solo economica) – diventano una risorsa l’una per l’altra, si sentono protagonisti fondamentali di un progetto comune e lo proteggono.
Lucia Magi


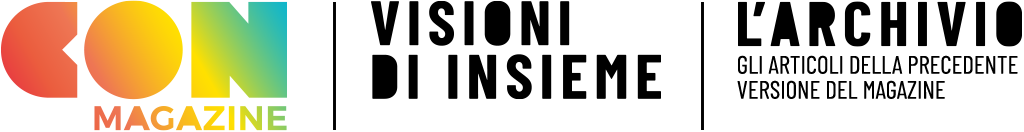



Nessun Commento