Quando ci siamo scordati che abitare in famiglie mononucleari, rinchiusi tra le quattro mura di un appartamento, non è l’unico modo di vivere?
Quand’è che le nostre case hanno smesso di prendere forma e crescere, insieme a noi e ai nostri cari? Quando abbiamo iniziato a delegare agli altri la costruzione di quella che l’artista e architetto Hundertwasser definisce la nostra terza pelle – e che in quanto tale, senza cambiamento, si irrigidisce e muore?
Andrea Staid (1), nel suo libro “Abitare illegale. Etnografia del vivere ai margini in Occidente”, accompagna il lettore alla riscoperta del profondo rapporto fra uomo e abitazione. Lo fa in modo polifonico, raccontandoci di coloro che, a pochi passi da noi, vivono in modo informale o illegale. Per scelta, risignificando i propri spazi, o per necessità, mettendo in atto rituali di resistenza.
Il racconto delle diverse declinazioni dell’abitare inizia con un capitolo dedicato ai romanés, popoli che hanno alle spalle una lunga storia di resistenza in nome di uno sfrenato amore per la libertà. Le voci riportate sono molte. Alcune, più politiche, contestano il superamento dei campi, altre raccontano l’aspetto sociale, la struttura della famiglia allargata per cui “apriamo la porta e abbiamo qualcuno pronto ad aiutarci”, altre ancora sono più personali: “Mi ricordo da ragazzino avrò avuto 12 anni, con la mia famiglia viaggiavamo ancora con i carri e i cavalli. Ho un ricordo che per me è molto importante, ero piccolo e viaggiavamo e una sera al tramonto mio padre vede un’area che gli piace e allora ha parcheggiato lì. Io dormivo, ci fermiamo mi sveglio lentamente, mi affaccio dal carro e vedo lì nell’imbrunire mia madre che sta facendo il caffè e il latte per noi. Insomma, mi sveglio e rimango così innamorato da questa immagine. Vedi, questa cosa ti sembrerà piccolissima e invece mi ha segnato nel profondo. Mio padre lì che accudiva i cavalli e li legava, aria pura, libertà e noi lì simbolo sicuramente di povera gente, ma libera, cosa bellissima nella propria povertà, ecco vedi, questo per me è il simbolo della libertà che ti dà il senso della vita”.
Staid prosegue con la narrazione delle occupazioni, soffermandosi in particolare sulle esperienze di Milano e Barcellona. Le occupazioni sono pratiche che vanno al di là di un semplice “mettersi contro” all’ingiustizia delle case sfitte (ci sono più case senza gente che gente senza casa), ma costruiscono intorno a loro una controcultura ed una rete di reciprocità. A Milano, per esempio, esiste un cosiddetto “welfare autogestito” e creato dal basso, fatto di scuole di italiano per migranti, mercatini autogestiti di prodotti biologici, sport popolare gratuito per tutti, doposcuola per bambini, feste e cineforum. Dove ci sono le case occupate, spiega Said, c’è meno degrado e le possibilità sociali aumentano. Le occupazioni rappresentano anche una risposta alla trasformazione delle città in vetrine per turisti, che ignorano le esigenze di chi le abita quotidianamente, come nel caso di Barcellona.
“Abitare illegale è – anche- permettersi qualcosa che ti è negato, vivere al di sopra delle possibilità date in partenza, mi sono presa quello che non mi avrebbero mai dato, mi sono presa la bellezza. Mi sono presa la mia intelligenza. (…)” – come testimonia una ricercatrice che, volendosi permettere una casa in affitto, avrebbe dovuto svendere il proprio tempo per fare qualche altro lavoro, invece di inseguire i propri sogni.
Lontano dalle città e dalle sue periferie troviamo una resistenza un po’ diversa, silenziosa e profonda, che si manifesta nella diffusione e nella crescita di comunità, ecovillaggi, fattorie anarchiche e villaggi spirituali. Siamo di fronte a realtà molto eterogenee, che associazioni come GEN (Global Ecovillages Network) e, in Italia, RIVE (Rete Italiana Villaggi Ecologici) si impegnano a mettere in rete. Ad accomunarle, il desiderio di portare un cambiamento partendo da un diverso modo di impiegare il proprio tempo, consumare, relazionarsi, prendere decisioni insieme.
Il penultimo capitolo è dedicato all’autocostruzione, argomento vasto, che va dalla manutenzione delle case popolari occupate all’autocostruzione dopo il terremoto. In un’epoca che esalta la specializzazione, riappropriarsi del saper fare vuol dire riprendersi la propria libertà, materiale e mentale. Uno spazio importante è dedicato agli “autocostruttori consapevoli” che, dopo il terremoto in Emilia, hanno rifiutato di vivere rinchiusi nei container, aspettando che fosse lo Stato a ricostruire, ma di attivarsi in prima persona, con finalità che vanno dalla volontà di bloccare la speculazione edilizia e l’infiltrazione mafiosa, al desiderio di rinsaldare la comunità e di riattivare l’economia locale attraverso cantieri scuola. “Autocostruire per autocostruirsi è ancora più importante dopo una tragedia naturale, bisogna far lavorare la gente dopo un terremoto, i bambini e anche gli adulti terrorizzati dal sisma se rimangono inermi dentro anonimi e freddi container si deprimono totalmente, autocostruirsi la propria casa o baracca temporanea è la possibilità di rinascere. Abitare non è solo la casa che hai, ma il contesto nel quale è inserita.”
Staid, infine, fotografa le condizioni di vita di coloro che si spingono alle frontiere della fortezza occidentale per cercare nuove possibilità di riscatto sociale, ritrovandosi schiacciate ai margini, in slum urbane e baraccopoli.
Uno dei fili rossi dei diversi modi di abitare che Staid porta è la relazione, l’appartenenza. E mentre in Europa, in Italia, televisioni e social media seminano angoscia e paura, invocando una sicurezza che è sinonimo del chiudere la porta a doppia mandata (o addirittura dell’avere delle armi in casa), viene da chiedersi se non sia preferibile la sicurezza dell’appartenenza, delle relazioni, della condivisione, delle porte aperte.
Cristina Diana Bargu


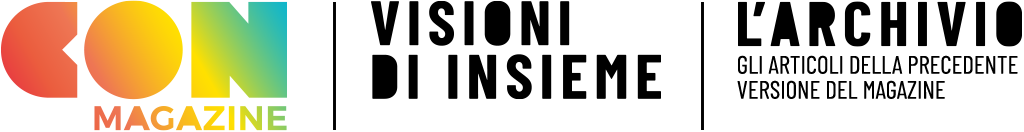
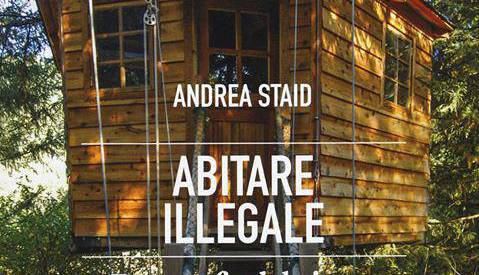


Nessun Commento