Possiamo allungare e allargare la nostra vita, ma prima o poi finiamo. La premessa della mia idea di sud è questo confronto ad occhi aperti con il mondo, con la vita e con la morte. Ma un acuto sentimento della nostra finitezza non basta: ad esso dobbiamo accoppiare, è questo il punto cruciale, un’idea alta dell’uomo. E questa idea alta dell’uomo a me sembra sia garantita dal sentimento dell’onore, purché esso venga radicalmente spogliato da quegli orpelli del potere e del possesso, che a lungo ne hanno disonorato il nome. Ancora oggi l’onore costituisce la bussola migliore per chiedere ad ogni essere umano di dare il meglio di sé anche quando farlo costa qualcosa. Si può essere grandi anche se non si è ricchi e potenti. Né bisogna invocare rendite per ciò che si è fatto prima, bensì cominciare ogni giorno di nuovo. Questo è il sud a cui voglio bene. E non mi sembra poco.
Questa mattina si è spento Franco Cassano, sociologo e padre del “pensiero meridiano”. Vogliamo ricordarlo con l’intervista integrale realizzata a vent’anni dalla sua celebre pubblicazione e tratta da “Con il Sud – #unfuturomaivisto. Visioni e storie di un’Italia che può cambiare“, volume a cura di Andrea Di Consoli e Yari Selvetella e promosso dalla Fondazione CON IL SUD (Mondadori, 2016).
Franco Cassano, sono trascorsi esattamente vent’anni dalla pubblicazione del suo testo più conosciuto e discusso, Il pensiero meridiano. Quel suo libro ebbe la forza di donare allo sguardo da Sud una prospettiva nuova, “autoctona” e, in qualche misura, orgogliosa, benché umile, fraterna, poetica. A vent’anni di distanza, ovviamente non da un punto di vista stilistico, lo riscriverebbe allo stesso modo?
Venti anni passano per tutti, anche per i libri, e sicuramente sono cambiati il quadro e il tono dell’epoca. A suo tempo l’eco del libro fu grande perché dava voce a un sentimento diffuso di ribellione contro quella chiusura della mente che, ben al di là dei confini del leghismo, era appoggiata sulla stolida riduzione della differenza meridionale ad un insieme di arretratezze e patologie. Ma il libro era tutto tranne che la celebrazione di un fondamentalismo di segno opposto, una forma di regionalismo teorico reattivo. Come testimoniano i riferimenti bibliografici, il libro veniva da una ricognizione del dibattito teorico europeo, anticipando per certi aspetti i temi che sarebbero stati proposti solo qualche anno dopo dalla critica post-coloniale. Venendo alla sua domanda le dico che di fronte a tanti cambiamenti lo scriverei in modo diverso, ma, anche che quel crampo del pensiero che impedisce di capire il sud è ben solido e va anche oggi combattuto con fermezza.
Ma per mettere a fuoco i cambiamenti intervenuti rispetto al periodo in cui il Pensiero meridiano vide la luce occorre ritornare al clima degli anni Novanta. Sono gli anni in cui, dopo la caduta del muro, la storia prende una strada che a molti apparve come un nuovo inizio carico di promesse. Non penso solo alle tesi ingenuamente apologetiche di Fukuyama sulla fine della storia, ma anche alla “mondializzazione felice” di Alain Minc; accanto al trionfalismo dei vincitori, c’era la ricerca di strade diverse da quelle fino ad allora battute. Sono gli anni di un’espansione intensa e continua, ma anche del rilancio dell’Unione Europea, gli anni del partenariato euro-mediterraneo, un tentativo gracile, ma significativo, di cambiare il rapporto tra l’Europa e il suo sud. Soprattutto si diffonde la convinzione, seppur diversamente modulata, che il mondo globale avrebbe portato progressivamente al superamento dei confini e al rimescolamento delle identità.
Si trattava di una lettura generosamente irenistica della storia, che vedeva le pulizie etniche che infestavano la crisi iugoslava più come il retaggio di un passato arcaico che non come un assaggio del mondo futuro. La globalizzazione appariva capace di garantire una crescita continua, l’affermarsi di un gioco a somma positiva in cui tutti potevano vincere qualcosa. E questo intreccio di dinamismo e mobilità sembrava offrire l’occasione per associare i popoli decostruendo i vecchi recinti identitari. La stessa crisi degli stati nazionali poteva essere superata dai nuovi soggetti collettivi in costruzione (l’Unione Europea in primo luogo, ma anche le diverse forme di governance a livello globale) coerentemente con la convinzione che l’umanità, pur con incertezze e resistenze, stesse marciando verso uno stadio più evoluto della propria organizzazione.
Il pensiero meridiano non s’identifica certo con questo entusiasmo e con le magnifiche sorti e progressive del nuovo capitalismo globale. Ne rappresenta anzi un contrappunto critico serrato, che, prendendo di mira la nuova ideologia della competizione (l’integralismo della corsa), rilancia l’idea di una civiltà capace di governare la modernità, di conferirle una “misura”, una lettura molto diversa per esempio rispetto a quelle di Giddens e Beck, che di quel passaggio sottolineano soprattutto le virtù. C’è però un tono che il pensiero meridiano condivide con il clima del decennio, un’antropologia ottimistica, la fiducia che fosse possibile costruire una storia nuova, che la vocazione all’incontro dei popoli potesse prevalere sul richiamo identitario e fondamentalista. Il Mediterraneo vi veniva rappresentato come il mare della convergenza, e insieme come lo strumento per superare la posizione periferica del sud italiano, un’arteria decisiva dello scambio tra le civiltà. E tutto questo non per confinarsi a sud, per creare un’area periferica arcaica, ma per far partire da lì la proposta della “misura”, dell’equilibrio tra terra e mare, tra libertà e radici. Questa contrapposizione agli opposti fondamentalismi, consegnata nel secondo capitolo del libro, che ne costituisce l’armatura teorica non sembra abbia perso il suo significato.
Ma, a partire dall’11 settembre e dalla spirale ritorsiva a cui esso ha dato vita, il quadro si è molto complicato. Le rive del Mediterraneo sono tornate ad allontanarsi, risucchiate da una sorta di deriva identitaria dei continenti. La globalizzazione è divenuta inquieta e tutt’altro che felice, anche perché, a partire dal 2007, a questo quadro geopolitico difficile si è venuto a sommare l’arresto della crescita, quel collante laico e secolarizzato che a lungo ha garantito la coesione delle democrazie dell’Occidente: la ricchezza non cresce più, ma si riduce, inasprendo sospetti e conflitti. E’ questo contrarsi degli spazi, interni ed esterni, che oggi dà il tono all’epoca, un tono che alimenta più la paura che la speranza e spinge a cercare nei vicini non soci ed amici ma responsabili e nemici. Rendendo il mondo più piccolo, la globalizzazione lo ha reso anche più affollato.
Gli stati nazionali sono in crisi, mentre le merci, le idee e i processi economico-finanziari – e, in parte, anche quelli politici – sono sempre più globalizzati. E’ in atto, insomma, un grande e contradditorio rivolgimento di popoli e di identità, un’apertura tumultuosa del mondo – con momenti regressivi, con battute d’arresto clamorose ma comprensibili. Ha ancora senso ora che si è innescato questo flusso e questo rivolgimento finanche brutale e travolgente parlare in maniera conchiusa di Sud, di Meridione d’Italia? Detto in alteri termini: ha senso la questione meridionale all’interno della questione globale?
I sud hanno tratti comuni, ma sono anche molto diversi tra loro: che rapporto c’è tra il nostro sud e quello dei migranti che in questi anni mettono a rischio la vita per arrivare sulle nostre rive? Rispetto a loro noi siamo nord, il primo approdo di quell’area ricca del pianeta che aspirano a raggiungere. Diceva con una splendida battuta Bellavista/De Crescenzo: si è sempre meridionali di qualcun altro. E ovviamente la battuta potrebbe essere rovesciata: si è sempre anche settentrionali di qualcun altro. Le differenze tra i vari sud non solo esistono, ma crescono e possono diventare conflitti, specialmente in un pianeta nel quale si allarga la concorrenza e chi ha conquistato un minimo di sicurezza ha paura di chi, offrendosi a prezzi più bassi, sembra mettere in discussione quello che era stato faticosamente conquistato. Prima di mettere in un solo fascio tutti i sud è bene quindi riflettere con attenzione. Certo, in una poesia di Jimenez o di Borges si possono trovare versi folgoranti, così come tanti romanzi raccontano storie di sud lontani che hanno qualcosa di famiglia. E questi testi aiutano a sporgere la testa fuori del conformismo del nostro tempo, ad apprezzare un procedere meno affogato nell’euforia dell’attimo fuggente, che cancella tutto ciò che abbiamo alle spalle o davanti. Conoscere il valore della sosta e della lentezza, è un esercizio che allarga l’anima, e non per caso il primo capitolo del Pensiero meridiano era dedicato a questa esperienza. Ma il pensiero meridiano è il titolo di un intero libro e non di un solo capitolo, magari il più suggestivo. Anche perché ai capitoli già scritti ne andrebbero affiancati altri capaci di confrontarsi con la molteplicità e la contraddittorietà dei sud. Per parte mia ho cercato di farlo soprattutto in Tre modi di vedere il sud, nel quale cercavo di complicare il quadro proposto dal pensiero meridiano.
Ad esempio oggi in Italia per uscire dalla continua oscillazione tra l’esortazione moralistica al sud ad abbandonare i suoi vizi (alzati e cammina!) e il vittimismo neo-borbonico (la colpa è degli altri), varrebbe la pena di concentrare l’attenzione su un punto teorico di cruciale importanza: la depressione e l’inerzia oggi dominanti a sud non sono la causa, come si ama pensare, del divario rispetto al nord, ma almeno in parte anche il suo prodotto. Infatti le aree che costituiscono il centro di un’economia, essendo più dinamiche ed efficienti, sono quelle che attirano investimenti e forza-lavoro, vivono di una spirale virtuosa, che assicura loro un vantaggio cumulativo. Le periferie al contrario, essendo meno efficienti e sicure, perdono investimenti e forza-lavoro, la quale va a cercare nelle aree centrali lavoro e salari più sicuri: un circolo vizioso che produce uno svantaggio cumulativo. Ad ogni giro il centro diventa più efficiente e sicuro di sé, mentre la periferia perde fiducia e si deprime, facendosi risucchiare dalle patologie che l’accompagnano ovunque. Il punto drammatico è tutto nel dislivello di forza iniziale: uno scarto iniziale minimo, crescendo ad ogni giro, allontana non solo i livelli di vita delle due aree, ma anche la loro qualità etica e la loro capacità di comunicare: la più forte è sicura di dovere la propria fortuna solo a se stessa, la seconda è tentata di attribuire la propria sfortuna allo sfruttamento altrui. Ma questo non succede solo da noi, perché è la legge di ogni rapporto tra centro e periferia. Rompere questa spirale è il compito delle classi dirigenti di ogni sud. Non si tratta di un destino immodificabile, ma invertire questo circolo vizioso richiede politiche coraggiose, il contrario della rassegnazione.
Parole come “identità” e “radici” stanno diventando parole difficili, quasi impossibili. I meridionali dovrebbero attenersi più al metodo conoscitivo “conosci te stesso”, e dunque definire il perimetro preciso della propria forma identitaria e lì mettersi al sicuro, oppure aprirsi senza troppe protezioni al flusso del moderno, del plurale, del relativo globale?
C’è il libro di un filosofo tedesco che ha per titolo: quanta globalizzazione possiamo sopportare? E’ una domanda cruciale. La globalizzazione crea incertezza, l’hanno chiamata “società del rischio”, “modernità liquida”, un mondo in cui il battito d’ali di una farfalla può produrre effetti imprevisti a migliaia di chilometri di distanza. Il ritorno delle identità nasce anche da questa declinazione globale della modernità, dal timore di smarrirsi in un universo che sembra renitente ad ogni forma, che premia i più forti lasciando gli altri alla deriva. Il riaffacciarsi delle identità e delle frontiere, la rivendicazione delle radici della lingua e della religione nascono dal bisogno di non rimanere nudi in un mondo di cui non si vedono i confini, da un bisogno di legami forti e fedeli. E del resto il bisogno di frontiere appartiene anche ai più forti, che dagli Stati Uniti a molti paesi europei non hanno nessuno scrupolo a costruire muri controllati da guardie armate.
Ma il sud italiano non è solo la parte meridionale dello stivale, è un contesto, un insieme di relazioni di cui il Mediterraneo è il simbolo. Il sud italiano non è solo terra, ma anche mare. Se esso smarrisce, come spesso è accaduto, la propria intelligenza geopolitica e perde il sogno di diventare il fulcro di un mondo diverso, muore. Rispetto ma non amo il sud arroccato su se stesso, quel sud che vede la modernità solo come una malattia, che non capisce che il suo grande passato è una storia di terra e di mare, quella della modernità di allora. Certo, oggi una proiezione così larga è resa difficile da quella deriva dei continenti che ricordavo all’inizio, ma un sud isolato dal mondo che lo circonda, un sud che non provi ad essere insieme locale e cosmopolita non varcherà la soglia dell’indotto turistico, avrà gli animatori, ma avrà perso l’anima. E questo non per una condanna snobistica del turismo, ma perché un’identità è una cosa seria solo se non ha paura delle sfide che il mondo gli lancia e non si riduce ad una celebrazione infinita e malinconica di se stessa.
Ogni meridionale è il Sud, così come ogni morto è la morte. Esiste dunque un’idea di società, di mondo, di destino, di tempo che funga da comune denominatore per coloro che, per appartenenza geografica e storica, siamo soliti definire italiani del Sud Italia?
L’Italia del sud è da sempre una terra di arrivi e partenze. L’elenco di coloro che ci sono sbarcati è lunghissimo e la nostra migliore qualità è quella di essere “meticci”, incroci tra voci e popoli diversi, soci fondatori di un universalismo plurale, di un disordine nel quale siamo abituati a vivere mescolando i vocabolari, i nomi e i cognomi delle persone. La nostra musica non è quella da camera, splendida e raccolta, ma è quasi sempre arricchita dalla presenza della voce, allo stesso tempo più sentimentale e meno distillata, poco distante dal rumore e dalla strada. Ad alcuni questo disordine può sembrare un limite e probabilmente lo è, ma è anche una virtù, perché quando qualcuno arriva da fuori fa sì che si avverta meno il cambiamento, mentre un salotto educato all’arrivo di un ospite inatteso percepisce subito la dissonanza e reagisce chiedendo l’immediato allontanamento dell’estraneo. Ma so per esperienza che anche queste qualità non vanno troppo decantate perché il successo le può corrompere o inquinare. Il rumore della festa può trasformarsi nello stupro dei luoghi, in un’anomia etilica e in una speculazione selvaggia che affoga il mare. Troppe lodi ai meridionali corrono il rischio di creare loro degli alibi e di farli rassomigliare ai siciliani del Gattopardo, che si sentono perfetti. Di tutto abbiamo bisogno tranne che di gente che si senta perfetta.
Come legge Franco Cassano – il sociologo, il filosofo, il politico, lo scrittore – il presente e il futuro delle migrazioni verso l’Italia? E in che modo il Sud potrebbe e dovrebbe approcciarsi a questo movimento epocale di uomini? Come dovremmo disporci rispetto a questi continui arrivi?
Abbiamo già parlato della moltiplicazione dei sud. Le emigrazioni non sono solo verso l’Italia, che è soprattutto luogo di approdo e di passaggio: Ventimiglia e Calais ci ricordano che i migranti vogliono andare verso i paesi che sembrano offrire più chances. Tutti i demografi sostengono che siamo di fronte ad un processo che, raddoppiato dalle guerre, è destinato a durare e a crescere, uno dei fenomeni più sconvolgenti del nostro tempo. E anche chi a lungo si è identificato come meridionale di qualcuno si accorge di essere settentrionale di altri e talvolta di molti altri. E questo processo disorienta gli allineamenti politici tradizionali, in primis la contrapposizione tra destra e sinistra. Ognuno scopre di essere conservatore rispetto a qualcun altro, di far parte di una piramide in cui ha sì sopra di sé altri, di cui critica i privilegi, ma anche di avere sotto di sé altri, e forse di più, che guardano ai suoi diritti come altrettanti privilegi. Si è, nello stesso tempo, la destra di qualcuno e la sinistra di qualcun altro. E in questa disseminazione dei conflitti gli appelli nazionali, etnici e religiosi sembrano avere più concretezza e più appeal rispetto alla contrapposizione tra destra e sinistra. Se la sinistra europea non trova modo di dare qualche segnale di vita corre il rischio di diventare un reperto del secolo scorso. Non è un caso che un’idea di unificazione dei diversi sud arrivi più dal pontificato di un papa venuto dai confini del mondo, più dall’universalismo religioso che dalla politica. Che fare? Essere saggi, capire che questo esodo massiccio va affrontato e governato, che l’apertura totale permetterebbe alla destra di allargare la schiera della paura e del razzismo e la chiusura totale sarebbe una sconfitta preventiva ed auto-inflitta. Diceva il Che: essere duri senza perdere la tenerezza. Noi potremmo dire: governare i flussi senza perdere l’universalismo. Sapendo che gli slogan sono sempre più rotondi e rassicuranti della realtà, la quale reagisce male ad ogni semplificazione.
Vorrei ora sottoporle due problemi: il primo riguarda la bellezza. Non crede anche lei che la bellezza, intesa in senso spaziale, prima o poi finisca sempre nelle mani dei più ricchi? Insomma, è possibile al Sud, per parafrasare il titolo di un altro suo fortunato libro, un’umiltà della bellezza?
La bellezza ha un’antica debolezza per il potere e il danaro. Non bisogna illudersi: quasi sempre essa si vende al migliore offerente, dalla bellezza fisica ai grandi progetti dell’arte. Ma a questo recinto che la isola e la mette nelle mani dei potenti non si deve reagire abbassando la soglia della bellezza, pensare che se ne possa inventare un’altra facile e per tutte le tasche. La bellezza è una cosa diversa da ciò che piace, custodisce un attrito con ciò che è facile e banale. Avvicinarsi alla bellezza deve richiedere uno sforzo, una preparazione. Detesto che nelle notti estive quell’enorme ed inquietante spettacolo che è il cielo venga osservato solo come il teatrino di qualche stella cadente alla quale legare la realizzazione di un proprio desiderio. Si leva il capo, ma non si vede nulla. Guardare il cielo significa invece avvertire la paura che viene da quella volta immensa, e saperla trasformare in stupore ed ammirazione. La bellezza è rara e va cercata: umiltà non vuol dire renderla facile. Essa va meritata.
Il secondo problema riguarda il tramonto del sacro, la morte, anche al Sud, di Dio – ovviamente parlo di una tendenza, non di una realtà univoca. Franco Cassano vede forme superstiti di sacro nel Sud di oggi?
Potrei risponderle con una battuta: oggi nel sud la parola resort non ricorda più a nessuno la Resurrezione di Gesù, ma solo luoghi esclusivi per le vacanze dei vip. Ma se in giro ci sono quelli che uccidono e si fanno uccidere in suo nome Dio non deve essere morto dappertutto. La verità che la religione, diversamente da quando negli anni Sessanta si parlava di secolarizzazione, è dura a morire. Certo, Dio è molto meno presente nei nostri comportamenti quotidiani, e ci è sembrato che la vecchia provvidenza potesse essere sostituita dalla previdenza, che la tecnica e le conquiste sociali ci potessero tenere al sicuro. Oggi quell’epoca ci appare lontana, troppo sicura della propria potenza. In un mondo pieno di incertezze e di paure in cui tutti i legami sembrano diventare precari la religione sembra riaffacciarsi. E questo riaffacciarsi del religioso è un fenomeno complesso, in cui ci sono le processioni per sedurre i turisti, le fobie nei riguardi della scienza, i fanatismi sanguinari in nome di Dio, ma anche la cura quotidiana di chi sta male, e il tentativo di dare voce a chi non ce l’ha, di fare attrito con un mondo ingiusto. Non riesco ad accettato tutto in blocco, alcune di queste forme del religioso mi lasciano freddo, altre mi ripugnano, altre ancora mi sembrano degne di straordinario rispetto, un grande aiuto per costruire il futuro.
Oggi a cosa vuole bene, nel Sud, Franco Cassano?
Farò un esercizio molto parziale scartando di proposito ciò che del sud non mi piace e sento lontano. Il punto di partenza è il sentimento della propria finitezza, l’idea che il mondo non è a nostra disposizione, anche se, tramite la tecnica, riusciamo, almeno in parte, a dominarlo. Possiamo allungare e allargare la nostra vita, ma prima o poi finiamo. La premessa della mia idea di sud è questo confronto ad occhi aperti con il mondo, con la vita e con la morte. Ma un acuto sentimento della nostra finitezza non basta: ad esso dobbiamo accoppiare, è questo il punto cruciale, un’idea alta dell’uomo. E questa idea alta dell’uomo a me sembra sia garantita dal sentimento dell’onore, purché esso venga radicalmente spogliato da quegli orpelli del potere e del possesso, che a lungo ne hanno disonorato il nome. Nel pensiero meridiano, sulla scia di Camus, ma anche di Simone Weil, avevo già avuto modo di parlarne. Ancora oggi l’onore costituisce la bussola migliore per chiedere ad ogni essere umano di dare il meglio di sé anche quando farlo costa qualcosa. Si può essere grandi anche se non si è ricchi e potenti. Né bisogna invocare rendite per ciò che si è fatto prima, bensì cominciare ogni giorno di nuovo. Questo è il sud a cui voglio bene. E non mi sembra poco.


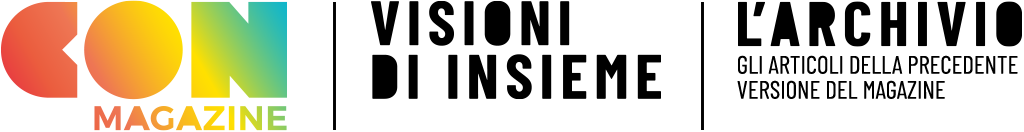




Nessun Commento